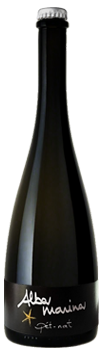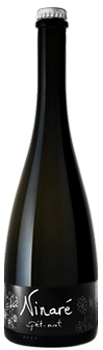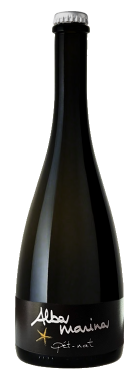Le dinamiche macroeconomiche di globalizzazione dei mercati e i loro effetti sul mondo del vino, in particolare sui piccoli produttori.
Oggi ho letto un articolo interessantissimo tratto da un libro di geografia economica nel quale Raphael Schirmer spiega in maniera molto chiara le dinamiche che hanno portato alla globalizzazione nel mondo del vino. Tale globalizzazione, secondo l’autore, si è sviluppata a partire dai grandi investimenti in vigneti effettuati nel secondo dopoguerra nei Paesi del Nuovo Mondo: USA, Cile, Argentina e Australia in testa.
L’aumento di tali investimenti e, quindi, l’impiego massiccio di capitali che necessitano di un ritorno altrettanto massiccio, ha generato alcuni fenomeni che in pochi decenni hanno cambiato il volto del settore vinicolo.
1) Prima necessità: standardizzazione.
La standardizzazione è stata necessaria per produrre vini semplici che fossero il più possibile uniformi, indipendentemente dall’annata e dal luogo di produzione: produrre vini varietali, ossia usando una sola varietà di uva, ha semplificato le cose sia per i produttori, che si sono affrancati dalla difficoltà di realizzare blend complessi, sia per i consumatori, che hanno finalmente avuto uno strumento chiaro e riconoscibile per identificare i vini, ossia il nome dell’uva. Il nome della varietà, stampato chiaramente sulle etichette, ha semplificato la comunicazione e ha tranquillizzato il consumatore, aiutando anche il meno esperto nella scelta del vino da acquistare.
2) Seconda necessità: industrializzazione.
L’aumento degli investimenti nel settore vinicolo da parte di gruppi sempre più grandi ha generato l’esigenza di sostenere il costo stesso degli investimenti, quindi ha spinto verso aumenti di produzione sempre più consistenti. Gestire volumi di produzione sempre crescenti ha creato l’esigenza di abbreviare i tempi di lavorazione e standardizzare le lavorazioni stesse, stimolando un’innovazione tecnologica che è stata largamente adottata nelle cantine: presse pneumatiche, fermentazioni controllate, alta velocità di imbottigliamento, controllo delle temperature sono solo alcuni esempi dell’introduzione di tecniche industriali nella produzione del vino.
3) Terza necessità: modernizzazione.
L’aumento degli investimenti ha portato ad una importante concentrazione del settore, oggi in mano a potenti oligopoli. Ciascun oligopolio ha mirato all’acquisizione dei concorrenti rimasti, ricorrendo per lo più al credito bancario e al mercato finanziario: l’entrata in borsa dei grandi gruppi ha ulteriormente esasperato la necessità di remunerare velocemente i capitali investiti, fino al punto che la necessità di produrre grandi volumi di vino e di venderli in tempi brevi ha completamente soppiantato i concetti tradizionalmente legati alla produzione vinicola, come quelli di terroir e di affinamento.
In questo contesto, le aziende più grandi del mondo non hanno avuto altra scelta che quella di trasformare il vino in una commodity che possa essere venduta e acquistata come qualsiasi altra merce, con tempi di produzione il più possibile brevi e con prodotti il più possibile omogenei per poter raggiungere un pubblico sempre più vasto. Le stesse aziende continuano a produrre, insieme ai vini di mass market, anche piccolissime quantità di prodotti di alta gamma sui quali non guadagnano affatto, ma che considerano esclusivamente investimenti pubblicitari, lasciando che siano questi vini top ad accreditarli come produttori di qualità.
Un ruolo molto importante in questo processo è stato rivestito dai critici del vino: l’autore cita Robert Parker come l’epigono di una linea di pensiero che considera il terroir una scorretta rendita di posizione, un ostacolo alla liberalizzazione del commercio mondiale e una sostanziale truffa intellettuale.
Tutto l’articolo (in inglese) qui.
Crediti: ph courtesy wine-searcher.net
Tags: marketing del vino, mondo del vino, globalizzazione, Raphael Schirmer, mass market, mercato del vino